La funzione dell'ideologia del merito
Nel nostro tempo è sempre più comune un richiamo insistente alla meritocrazia, l’idea cioè che i più capaci e meritevoli devono emergere dalla massa ed essere riconosciuti come tali. Ma nella nostra società si può parlare davvero di meritocrazia? L’istruzione, che in questa visione dovrebbe essere il meccanismo che seleziona una capace classe dirigente, assolve davvero il suo compito? L’analisi delle condizioni socioeconomiche che hanno fatto emergere il concetto stesso di meritocrazia nella nostra epoca è sufficiente a suggerire il contrario: non solo, si può anche vedere che in un mondo di disuguaglianze parlare di meritocrazia assolve a una funzione ben precisa.

Il concetto di “meritocrazia” risale al 1958, quando Michael Young, scrittore, sociologo e attivista britannico coniò il termine nella sua famosa opera L’avvento della meritocrazia. Il libro descrive una società (distopica) dove il merito, inteso come combinazione di talento naturale e sforzo individuale, è diventato il principale metro di giudizio degli individui, e criterio conseguentemente sulla cui base sono allocati i privilegi sociali, quali lavori meglio remunerati, ricchezza e via dicendo. In questo mondo, gli individui sono testati fin dall’infanzia attraverso la scuola pubblica, che ha il compito di selezionare i più capaci, facendoli arrivare ai punti apicali dell’istruzione e conseguentemente del sistema socioeconomico. Il processo di selezione riguarda tutti, indipendentemente dal loro retroterra, e potenzialmente chiunque potrebbe arrivare ai vertici del sistema. L’esito del processo è una società dove bene o male tutti sono convinti di avere quello che si meritano: coloro che non sono riusciti a emergere, Young lo rimarca, sanno bene che la colpa infondo è loro, che sono stati a più riprese testati dal sistema e non si sono dimostrati adatti. Proprio per questo la legittimità della classe dirigente meritocratica è enormemente rafforzata: se quando il privilegio circolava per trasmissione ereditaria della ricchezza e nepotismi vari le masse potevano criticare l’ingiustizia della cosa, adesso esse sanno che tutte le possibilità sono state date anche a loro. È nella natura delle cose che alcuni non siano riusciti a emergere.
È interessante adesso notare come questo concetto sia passato nel discorso comune. Naturalmente, dalla meritocrazia di Young siamo lontanissimi: un sistema del genere richiederebbe riforme politiche di ampissima portata, e non si tarderebbe a vedere che la meritocrazia, per esempio, non va esattamente d’accordo con la proprietà privata. Si dovrebbe quindi procedere prima di tutto a limitare la trasmissione dei privilegi tra le generazioni, dal momento che i beni sociali dovrebbero essere continuamente riallocati ai meritevoli di ogni nuova generazione (attraverso proibitive imposte di successione, per esempio), nonché provvedere a che il benessere dei genitori non possa avere alcuna influenza sui risultati dei figli (punto su cui ritorneremo). È facile vedere che pochi tra gli apologeti della meritocrazia del nostro tempo sarebbero disposti a sottoscrivere questo tipo di misure, le quali nel libro sono invece tutte più o meno presenti.
Sia nell’opera di Young che nel nostro tempo, la meritocrazia si ricollega particolarmente all’istruzione: nel libro, infatti, è una scuola pubblica e universale che provvede a selezionare la classe dirigente sulla sola base del merito. Nella visione dei nostri fautori della meritocrazia, questo dovrebbe succedere anche oggi, e sebbene spesso sorvolino sul prestigio imperante delle forme di istruzione privata, questo non gli ha impedito di aggiungere la dicitura “e del Merito” al nostro Ministero dell’Istruzione. Per capire perché tuttavia l’istruzione sembri legarsi così strettamente al concetto di meritocrazia, dobbiamo prima chiederci che ruolo essa abbia oggi nella selezione della classe dirigente, e per comprendere ciò dobbiamo, ancora prima, guardare al suo ruolo nell’economia contemporanea.
Perlomeno nell’ultimo mezzo secolo il processo tecnologico ha reso sempre meno necessario il contributo del lavoro umano alla produzione. Ciò era prevedibile e previsto, tant’è che rimase famoso il parere di John Maynard Keynes secondo il quale nel futuro si sarebbe lavorato circa 15 ore la settimana. Questo, a causa di interessi economici contrastanti, non è avvenuto, e nel mentre l’avvento di un mercato del lavoro globalizzato ha ampliato a dismisura l’offerta di lavoro, anche a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli correnti sui mercati del lavoro nazionali. Questo processo – di cui già Hobsbawm, in chiusura del Secolo breve, prende nota indicandolo come una delle sfide dell’umanità del futuro – ha finito per lasciare sempre meno posti di lavoro e sempre più gente a contenderseli. Ed è qui che l’istruzione è entrata in gioco: dopo la grande espansione della frequenza dell’istruzione secondaria e terziaria, resa possibile dal welfare state del tardo XX secolo, anche le qualifiche, un tempo rare, sono arrivate ad essere in esubero rispetto alle esigenze di un mercato che di persone ha sempre meno bisogno.
Come scegliere dunque tra i molti qualificati per gli scarsi ruoli rimasti? Semplice, si è iniziato a preferire i portatori di diplomi emessi da istituzioni più prestigiose. Questo, soprattutto nel mondo anglosassone, ha finito per fare dell’istruzione d’eccellenza un potentissimo meccanismo di selezione (estremamente redditizio per le università), e di allocazione dei privilegi sociali. Ma queste istituzioni sono appunto anche le più costose: al netto di un numero relativamente esiguo di borse di studio, infatti, gli studenti provengono in genere da famiglie in grado di pagare le altissime rette, quindi già in posizione relativamente apicale nel sistema. Le famiglie possono utilizzare la loro già buona posizione per garantirne una comparabile ai figli.
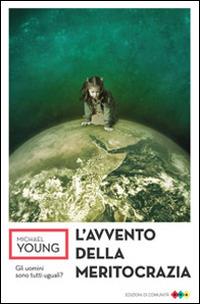
È recentemente emerso da un’inchiesta del New York Times che molti college americani hanno più studenti provenienti dall’1% più ricco della popolazione che dal 60% più povero, e un’immagine di cosa le famiglie più ricche siano disposte a fare per garantire ai propri figli l’accesso a queste istituzioni è bene illustrato in un recente docu-film disponibile su Netflix: Operazione Varsity Blues: scandalo al College, nel quale si racconta la storia vera di un giro di corruzione milionaria diretto ad aggirare i criteri di ammissione dei migliori college degli Stati Uniti (nonché le loro costosissime back doors, cioè la pratica delle famiglie abbienti di fare alle università donazioni multimilionarie per incoraggiare l’ammissione dei propri figli). Ancora, Andrea Mariuzzo cita The Chosen: The Hidden History of Admission and Exclusion at Harvard, Yale, and Princeton, di J. Karabel, dedicato a sviscerare le complesse contrattazioni e i vari interessi anche economici che stanno dietro ai criteri di ammissione degli atenei più prestigiosi. Oltre gli estremi del mondo anglosassone, anche da noi un welfare sempre più eroso finisce per (ri-)portare l’istruzione ad essere appannaggio dei ceti benestanti: chi ha le risorse può integrare il diploma con prestigiosi quanto costosi programmi post-laurea o tirocini presso soggetti prestigiosi che spesso sono non pagati, avvantaggiando di nuovo i soggetti provenienti dalle famiglie abbienti, che possono procrastinare la retribuzione.
L’istruzione “meritocratica” sembra essersi trasformata nel suo esatto opposto, ovvero in un meccanismo di perpetuazione del privilegio sociale. E in questo processo la meritocrazia svolge l’unica finzione che ha conservato da Young in poi: quella di legittimare una classe dirigente. L’ideologia del merito, con la sua retorica dell’eccellenza, permea il sistema, dagli atenei ai luoghi di lavoro, e conferisce al processo di selezione un’aura di imparzialità. Per questo meno il sistema diventa meritocratico, più sulla meritocrazia si deve insistere.
Man mano che ci si spostava da un economia basata sull’industria a una basata sui servizi, e quindi a maggior frequenza di lavoratori con una formazione universitaria, e contemporaneamente diveniva chiaro – con lo smantellamento del welfare state e la stagnazione economica delle fasce medie e basse della popolazione – che l’istruzione stava ritornando un privilegio di pochi, è stato necessario creare una retorica che non facesse pensare alle persone di essere state lasciate indietro, in un certo senso spostando su di loro la colpa per i fallimenti del sistema. Questa è la ragione per cui di meritocrazia si è iniziato a parlare negli ultimi anni, dal momento che il merito serve per definizione a spiegare/giustificare uno stato di cose in cui solo a pochi sono allocati benefici e privilegi, a giustificare, cioè, una selezione ove questa si renda necessaria. Questo stato di cose viene perciò legittimato agli occhi degli eredi di una sempre più debole classe media, le cui famiglie avevano migliorato la loro condizione nel corso del XX secolo traendo vantaggio da una diversa situazione economica. Queste fasce sono perciò più inclini, ritengo, a credere al concetto di meritocrazia: lo sforzo individuale, nella visione di molti, aveva permesso ai loro nonni di migliorare drasticamente il loro tenore di vita. Se oggi a noi, a differenza di chi ci ha preceduto, non riesce, questo non è per colpa di un sistema che è cambiato, ma della nostra individuale mancanza di capacità e di merito.
Le conseguenze di questo processo possono essere varie, ma qui mi vorrei limitare a prenderne in considerazione una in particolare: il processo di creazione di una élite insoddisfatta. Infatti, il sistema nel suo funzionamento esclude soggetti assolutamente capaci, non avendo le forse per assorbirli e le cui qualifiche sono quindi ritenute in esubero. Facendo così, tuttavia, prepara potenzialmente un grande catalizzatore del cambiamento sociale: tutte le grandi rivoluzioni, infatti, americana, francese o russa, furono guidate da un ceto intellettualmente preparato che però il sistema si era fatto antagonista. La meritocrazia, invece, inculcando l’idea che il sistema funziona e le colpe sono individuali, disinnesca un processo che tenderebbe a fornire alle forze di riforma della società una loro classe dirigente. L’ideologia meritocratica, infatti, si trova a dover evitare che rampolli intellettualmente dotati e organizzativamente capaci del ceto medio diventino forieri di malcontento: perché in un mondo sempre meno stabile sul piano politico, costellato di proteste e contestazioni, nessuno saprebbe dire dove un tale malcontento potrebbe portare.
31 ottobre 2023
SULLO STESSO TEMA
G. Zuppa, Ci meritiamo le disuguaglianze?
A. Zen, A scuola di inclusione
F. Lancia, L'università corrotta
