La sfida di una scelta: diritto, dignità e (fine)vita
Il tema del fine vita è al centro di un acceso dibattito tra diritto, etica e libertà individuale. Questo articolo analizza i casi Welby, Englaro e Antoniani-Cappato, evidenziando le differenze tra suicidio medicalmente assistito, eutanasia ed interruzione dei trattamenti di sostegno vitale. Attraverso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, si esplora il delicato equilibrio tra autodeterminazione e tutela della persona, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto e rispettoso su una questione che tocca la dignità umana.
di Emma Pivato
Il 14 marzo 2025 il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha promulgato la proposta di legge di iniziativa popolare n. 5, denominata Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019, già approvata dalla Regione lo scorso 12 febbraio.
Tale proposta legislativa ha suscitato le reazioni più disparate, come spesso accade quando temi eticamente complessi si trovano al centro del dibattito pubblico. Vatican News, ad esempio, riporta le parole del cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana, secondo il quale l’approvazione di una legge regionale in materia di suicidio medicalmente assistito «è davvero una sconfitta per tutti». Di avviso decisamente diverso è invece Giani, che già a febbraio aveva salutato con grande favore l’approvazione dell’atto: «Oggi dalla Toscana arriva un forte messaggio di civiltà».
Il tema del fine vita, a ben vedere, anima da tempo il dibattito italiano. Era il dicembre 2006 quando il dottor Mario Riccio interrompeva i trattamenti di sostegno vitale che garantivano la sopravvivenza di Piergiorgio Welby ed era il 9 febbraio 2009 quando, all’esito di una vicenda umana e giudiziaria a dir poco travagliata, giungeva la notizia della morte di Eluana Englaro. Era il febbraio 2017, infine, quando Fabiano Antoniani (DJ Fabo) si recava in Svizzera, accompagnato da Marco Cappato, per porre fine alla propria vita tramite iniezione letale.
Queste tre vicende, che spesso vengono impropriamente equiparate, presentano in realtà caratteristiche completamente diverse tanto dal punto di vista medico quanto da quello giuridico.
Se da un lato, infatti, non c’è dubbio che quelle di Piergiorgio Welby, Eluana Englaro e DJ Fabo siano tutte vicende che riguardano le fasi finali della vita di un individuo, dall’altro è altrettanto vero che non sono tutti casi di suicidio medicalmente assistito (né, come a volte si sente dire, di eutanasia).
Lo scopo che si propone questo articolo, quindi, è quello di dare un piccolo contributo per chiarire a cosa ci si riferisca, sul piano giuridico, quando si parla di fine vita, suicidio medicalmente assistito ed eutanasia. Per farlo ripercorreremo brevemente le storie dei tre protagonisti che abbiamo menzionato nelle righe precedenti.
Piergiorgio Welby era affetto da distrofia facio-scapolo-omerale, una malattia neuromuscolare degenerativa, che lo costringeva a dipendere da un respiratore meccanico per sopravvivere.
Considerato il proprio stato di salute, in fase irreversibilmente terminale, egli chiese di essere sedato e che la ventilazione automatica fosse sospesa. Welby era pienamente capace di intendere e volere e comprendeva perfettamente che ciò lo avrebbe portato alla morte. Quando Welby avanzò la propria richiesta, nel 2006, il panorama giuridico italiano fu costretto a confrontarsi con una situazione inedita. Da una parte, l’art. 579 del Codice penale puniva (e punisce tuttora) il reato di omicidio del consenziente.
Dall’altra, tuttavia, l’art. 32 della Costituzione statuisce chiaramente che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Era inoltre necessario valorizzare anche l’art. 13 della Carta costituzionale, che sancisce l’inviolabilità della libertà personale. Tutto ciò considerato, i magistrati che si trovarono a giudicare la condotta di Mario Riccio, l’anestesista che aveva sedato Welby per poi staccarne il ventilatore, ritennero di non procedere nei suoi confronti, valorizzando il dettato costituzionale e il diritto all’autodeterminazione del paziente.
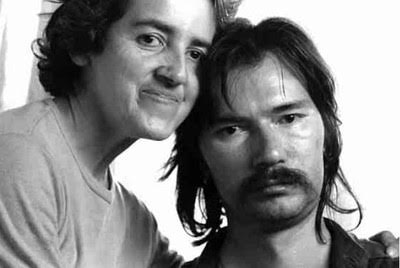
In sintesi, grazie all’impegno di Piergiorgio Welby, si è fatta strada nell’ordinamento italiano la possibilità per una persona capace di intendere e volere di chiedere che siano interrotti i trattamenti di sostegno vitale cui è sottoposta. Non si parla, in relazione al caso Welby, di suicidio medicalmente assistito.
Nel 1992 Eluana Englaro era stata vittima di un incidente che l’aveva ridotta in stato vegetativo permanente. Era quindi totalmente incapace di intendere e volere e, nonostante respirasse autonomamente, la sua sopravvivenza dipendeva dal sondino nasogastrico che la nutriva. Il padre di Eluana, Beppino Englaro, venne nominato suo tutore nel 1996 e nel 1999 iniziò la sua battaglia legale per poter sospendere le cure che tenevano in vita la figlia.
Egli difatti sosteneva che Eluana, che era sempre stata una ragazza energica e vitale, non avrebbe desiderato vivere nella condizione di coma in cui era. Rispetto al caso Welby, però, possiamo notare che sussiste una differenza notevole: se quest’ultimo domandava l’interruzione dei trattamenti per sé stesso, pienamente capace di intendere e volere, Beppino Englaro la chiedeva per un’altra persona che non era in grado di esprimere la propria volontà.
Dopo un lungo iter giudiziario, con sentenza n. 21748 del 2007, la Corte di Cassazione ammetteva che potesse essere autorizzata l’interruzione delle cure o dell’alimentazione artificiale di una persona a condizione che «la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile […]» e che la richiesta di interruzione «sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della volontà del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona».
Tenendo in considerazione ciò, una volta appurato quale sarebbe stata l’effettiva volontà di Eluana, ad esempio tramite numerose testimonianze rese da chi la conosceva, venne data l’autorizzazione a che i trattamenti sanitari che la tenevano in vita venissero sospesi. Sia nel caso Welby che nel caso Englaro, pertanto, la volontà della persona sottoposta ai trattamenti di sostegno vitale rimane centrale, seppur con le dovute differenze in merito alle modalità di accertamento.
Anche nel caso Englaro non si parla di suicidio medicalmente assistito.

È questo il panorama giuridico quando interviene la legge n. 219 del 2017, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (le cosiddette DAT). Con tale atto viene formalmente riconosciuta, per ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, la possibilità di esprimere anticipatamente la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
Tra le facoltà del soggetto rientra anche quella di esprimere anticipatamente il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Nel 2017, in sintesi, in Italia la situazione è la seguente: un individuo maggiorenne capace di intendere e volere può rifiutare un trattamento sanitario (quindi anche chiedere di sospenderne uno a cui sia già sottoposto) e può esprimere tale rifiuto anche in ottica futura ed eventuale.
Ciò che nel 2017 una persona non può fare è chiedere che il personale medico la aiuti ad auto-procurarsi la morte (suicidio assistito) o gliela procuri attivamente (eutanasia).
Giunti a questo punto della trattazione risulta opportuno esplicitare quale sia la differenza tra suicidio medicalmente assistito ed eutanasia. Ci si rifà alle definizioni offerte a tal proposito dal sito dell’Associazione Luca Coscioni, secondo cui «il termine eutanasia indica l’atto di procurare intenzionalmente e in modo indolore la morte di una persona cosciente e in grado di capire le conseguenze delle proprie azioni e che ne fa esplicita richiesta».
Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, qualora un medico iniettasse personalmente un farmaco letale ad un paziente tetraplegico che ne facesse richiesta. Per suicidio medicalmente assistito, invece si intende «l’atto attraverso cui la persona che ne fa richiesta, sempre nelle sue piene capacità cognitive, si autosomministra il farmaco letale per porre fine alle proprie sofferenze».
Ciò premesso, possiamo introdurre la vicenda di DJ Fabo con maggiore consapevolezza. Nel 2014 Fabiano Antoniani è vittima di un grave incidente d’auto a seguito del quale rimane cieco e tetraplegico. La sua vita dipende quindi da cure e trattamenti che lo aiutano nella respirazione, nell’alimentazione e idratazione e nell’evacuazione. La propria condizione di salute provoca a DJ Fabo sofferenze psichiche e fisiche intollerabili. Giunto allo stremo delle forze, quindi, manifesta la ferma volontà di porre fine alla sua vita all’inizio del 2017.
I casi Welby ed Englaro hanno già segnato, pertanto, uno spartiacque fondamentale nel mondo giuridico. Fabiano Antoniani, quindi, almeno astrattamente, potrebbe percorrere la stessa strada di Piergiorgio Welby: chiedere di essere sedato e, al contempo, che siano interrotti i trattamenti che lo tengono in vita. Tuttavia, date le condizioni cliniche peculiari di DJ Fabo, sospendere le cure significherebbe attendere il sopraggiungere della morte per un periodo di tempo prolungato, attraversando atroci dolori. Antoniani decide quindi di rivolgersi a Marco Cappato, attivista dell’Associazione Luca Coscioni, che lo mette in contatto e lo accompagna in una clinica svizzera dove DJ Fabo si autosomministra un farmaco letale.
Una volta tornato in Italia, Cappato si autodenuncia per aver commesso il reato di cui all’art. 580 del Codice penale (istigazione o aiuto al suicidio) che punisce «chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione».

Il caso di Marco Cappato arriva alla Corte Costituzionale. Ricordiamo che, nel 2018, vi è sì una legge (la n. 219/2017) che indubbiamente consente di rifiutare i trattamenti sanitari, ma non vi è nessuna legge (non c’è tutt’ora) che “vada oltre” a ciò e regolamenti quindi la possibilità di darsi attivamente, tramite aiuto medico, la morte. Per questa ragione la Corte, con ordinanza n. 207 del 2018, afferma che la materia è troppo articolata e complessa per essere affrontata tramite una pronuncia di un organo giudiziario e dà al legislatore il termine perentorio di un anno per intervenire a colmare il vuoto normativo. Un anno dopo la Consulta non può far altro che prendere atto dell’inerzia del Parlamento.
Con la sentenza n. 242 del 2019 viene stabilito che non si verifica il reato di cui all’art. 580 Codice penale qualora si fornisca aiuto al suicidio a una persona «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli». Tenuto presente tutto ciò, Marco Cappato non può dirsi colpevole per aver aiutato DJ Fabo a raggiungere la clinica Svizzera nella quale si è iniettato la sostanza letale.
Dopo la sentenza n. 242 del 2019, dunque, si apre in Italia un piccolo spiraglio per cominciare a parlare di regolamentazione della materia del suicidio medicalmente assistito, che diviene lecito nel caso in cui chi lo richieda versi nelle condizioni descritte dalla Corte costituzionale. L’eutanasia, invece, resta vietata nel nostro ordinamento. Dal 2019 ad oggi vi sono stati numerosi dibattiti in merito al fine vita, altri casi di richieste di suicidio medicalmente assistito si sono imposti all’attenzione delle cronache e alcune proposte di legge sono state presentate sia a livello nazionale sia a livello regionale. Tuttavia, al momento, solo la legge della Regione Toscana a cui si è accennato in apertura è stata ufficialmente approvata.

In conclusione ciò che preme ricordare è che il fine vita, ancor prima di essere un tema che necessita di regolamentazione giuridica, è una realtà che coinvolge vicende umane complesse e persone le cui necessità meritano di essere rispettate e valorizzate in un ambiente di ascolto e dialogo costruttivo. Ciò a prescindere dalla personale convinzione morale o etica alla quale ognuno è libero di aderire.
Articolo in collaborazione con Lindagine.it
16 aprile 2025
DELLA STESSA AUTRICE
Intelligenza artificiale: quali limiti?
SULLO STESSO TEMA
V. Fiore, Anche gli animali scelgono di porre fine alla propria esistenza?
